Le parole e le cose della prostituzione
Descrizione
Formato
/
Dottorato di Ricerca in Politica, Cultura e Sviluppo. Ciclo XXXI; Nel saggio Prostitution, quel est le problème , il ricercatore francese Lilian Mathieu si pone l’obiettivo di discutere con gli strumenti della filosofia e della sociologia la prostituzione. Il punto di partenza della riflessione è il registrare, da un lato, lo sforzo condotto da alcuni studiosi per dimostrare l’illegittimità o l’immoralità o l’inammissibilità della prostituzione, e dall’altro lo sforzo di altri studiosi, le cui voci si sono levate «pour défendre la légitimité de son exercice et exiger sa pleine reconnaissance» (Mathieu 2016, p. 10). Il problema che si pone Mathieu, il cosiddetto ‘problema della prostituzione’, sarebbe di tranciare il nodo gordiano del dibattito: trovare cioè chi ha ragione, coloro che considerano la prostituzione come immorale, illegittima, intollerabile (si noti che ognuno di questi aggettivi evoca questioni differenti e non trattabili come una sola), oppure coloro che la ritengono al contrario ammissibile (e anche questa ammissibilità andrebbe declinata).
Nelle pagine che seguono l’introduzione, Mathieu sviluppa la sua argomentazione: «trois pistes principales ont été envisagées, celles du désir, du consentement et de la vente du corps» (Mathieu 2016, p. 130). Il risultato dello sforzo di Mathieu è il seguente: «l’exercice n’as pas permis de départager laquelle de ces pistes est la mieux à même d’apporter une réponse définitive à la question posée [...] force est de reconnaître qu’en regard de son objectif de départ, notre enquête aboutit à un échec» (ivi). Segue specificazione: «il a été impossible de conquérir cette espèce de Graal des réflexions sur la prostitution qu’est l’identification d’une caractéristique qui légitimerait, en tout temps et tout lieu, de lui opposer un refus définitif» (ivi). Allo
stesso tempo: «cet échec n’en est pas un car il peut aisément être retourné. La prostitution ne pose pas un mais une série de problèmes différents qui, en outre, ne lui sont pas spécifiques» (ivi). In sintesi, Mathieu qui sta affermando che il suo tentativo di dirimere la questione della ammissibilità o inammissibilità (aggettivi qui usati in maniera consapevolmente generica) della prostituzione tramite una argomentazione filosofica che ha attinto anche alle «connaissances issues des sciences sociales» (ibidem, p. 11) ha fallito, in quanto: 1) non si è trovato un elemento che possa caratterizzare la prostituzione, cioè distinguerla in maniera non ambigua da altro che non sia, quindi, logicamente, prostituzione (e ciò per Mathieu, ha significato non riuscire a confermare argomenti che considerino la prostituzione inammissibile). Inoltre, (e ciò discende da quanto appena affermato):
2) il dibattito sulla prostituzione è costituito non una, ma da una serie di questioni , differenti tra loro, e che non sono specifiche di questo dibattito nel senso che esse possono essere poste anche in relazione anche ad altri temi, e potrebbero esistere anche se non esistesse il dibattito sulla prostituzione.
Questa posizione sulla prostituzione, cioè il ritenere che la prostituzione non sia definibile, individuabile in maniera non ambigua, ha delle conseguenze importanti. Infatti, se un fenomeno non può essere circoscritto, un oggetto non può essere
individuato, è impossibile (come ritiene lo stesso Mathieu) costruire un’argomentazione che conduca a evidenziarne i singoli aspetti, e a misurare questi ultimi adottando un criterio (qualunque criterio esso sia, di ammissibilità, di tollerabilità, di legittimità o qualunque altro criterio si voglia prendere in considerazione). Se si adotta la posizione di Mathieu, ne consegue che non sia possibile decidere chi abbia ragione sul dibattito sulla prostituzione, inteso come dibattito che affronta la questione della conformità o meno degli elementi che costituiscono il fenomeno prostituzione a criteri di ammissibilità, tollerabilità etc. Lo
stesso dibattito non sarebbe possibile, in quanto tali elementi non sarebbero individuabili, e potrebbe esistere solo nella forma di un dibattito sull’esistenza o meno del contenuto della parola ‘prostituzione’, e su quale forma questo contenuto abbia.
Assumendo che la posizione di Mathieu sia corretta, all’atto dell’indagare l’oggetto prostituzione, nella letteratura scientifica, – ma anche nel dibattito politico, nel dibattito dell’opinione pubblica a vari livelli, ci si aspetterebbe quindi di trovare un
dibattito tutto incentrato sul senso da dare al termine ‘prostituzione’. Laddove alcuni (forse) concorderebbero con Mathieu nell’evidenziare la difficoltà o impossibilità nel definire il termine, altri sarebbero contrari a tale posizione e proporrebbero forse
delle definizioni, ma comunque rispondendo alle perplessità evidenziate da Mathieu.
Oppure, ci si potrebbe aspettare che il dibattito sulla prostituzione sia addirittura inesistente. Invece, le cose non sono affatto così.
Secondo quanto riferito da molti osservatori, infatti, il dibattito sulla prostituzione, nel contesto delle democrazie occidentali, non solo è esistente, di lunga data, rovente, ma anche quasi esclusivamente affrontato nella forma della conformità o meno di ciò che è (o sarebbe) la ‘prostituzione’ rispetto a vari criteri (di ammissibilità, tollerabilità, legittimità etc.), e ciò è vero sia quando il dibattito avvenga tra soggetti che definiremmo ‘accademici’ (ricercatori, studiosi), sia nel dibattito politico, tra soggetti ‘decisori’, o ‘regolatori’, o ‘legislatori’, sia nel dibattito pubblico, cioè tra soggetti che non hanno altra qualifica se non il poter esprimere la propria opinione su un determinato argomento in un contesto in cui questa opinione ha modo di essere espressa e ascoltata (Mathieu 2004, Miriam 2005, Kantola e Squires 2004, Ditmore 2006, Outshoorn 2009). Non solo: di norma, pochi tra coloro che affrontano questo argomento chiariscono, preliminarmente all’esposizione della propria posizione, cosa si debba intendere per ‘prostituzione’ e perché. C’è, allora, da ritenere che Mathieu abbia sbagliato? Sembra ragionevole condividere la posizione di Lilian Mathieu sulla difficoltà di definire l’oggetto prostituzione. Percorrendo una strada autonoma, infatti, è possibile giungere alle medesime conclusioni. La presente trattazione intende pertanto muovere dall’affermazione di Mathieu,
assumendola come punto di partenza di una riflessione sul tema della prostituzione. L’impossibilità di definire la prostituzione sarà, in una prima fase, messa a confronto con le ricostruzioni teoriche della prostituzione presenti nella letteratura, le quali
saranno discusse criticamente e presentate in una tipologia dal valore espositivo. In seconda battuta, saranno prese in considerazione le rappresentazioni empiriche della prostituzione, sempre nell’ottica di sfidare criticamente la tesi della indefinibilità della prostituzione. Si giungerà così ad alcuni risultati: verranno messi in evidenza i molteplici significati attribuiti alla prostituzione nella letteratura, e la multiformità associata alla prostituzione nelle ricerche empiriche. Ciò condurrà a prendere in considerazione l’ipotesi che la prostituzione non abbia un contenuto proprio (in questo senso sarebbe indefinibile). Si contestualizzerà, dunque, tale affermazione rispetto a un itinerario storico-filosofico di contributi che condurrà a evidenziare
l’opposizione tra un approccio ‘oggettivista’ e un approccio ‘soggettivista’ alla questione del conoscere la realtà. Tale opposizione sarà discussa in generale, e in particolare in relazione alla questione del conoscere il contenuto della prostituzione.
Nel corso della discussione, seguendo le tracce di alcune riflessioni presenti nella letteratura, sarà formulata una proposta originale rispetto alla questione del definire la prostituzione. Tale proposta consiste nel riconoscere i limiti rispettivi di un approccio ‘oggettivo’ e ‘soggettivo’ alla questione della conoscenza della realtà, nel valorizzare le rispettive caratteristiche (intese come opportunità e come limiti) di ognuno dei due approcci, e nel concludere che, come suggerito dalla letteratura, entrambi siano necessari nello sforzo di ‘afferrare’ un dato contenuto. Sempre sulla scorta della letteratura, sarà suggerito che l’opposizione tra i due approcci possa essere messa in discussione, non solo nel senso di una alternanza fra approcci o compensazione reciproca, ma valorizzando la possibilità di un superamento che valorizzi la soggettività specifica.
Questo, per quanto riguarda il tentativo di definire la prostituzione, significa: riconoscere i rispettivi limiti delle rappresentazioni oggettive e soggettive della prostituzione; muovere nel senso di ancorare il processo di definizione della prostituzione alla specificità dell’esperienza soggettiva, di tutti i soggetti coinvolti nella prostituzione simultaneamente. La presente trattazione ha il proprio senso scientifico nell’osservazione che, né nella letteratura, né nel dibattito sulla prostituzione – pure abbondanti quanto a contributi e frequenza – esistano un catalogo critico delle rappresentazioni della prostituzione che abbia anche una certa ampiezza, e soprattutto una discussione teorica approfondita (cioè che ragioni sul perché) della possibilità teorica di definire la prostituzione, nonostante questa questione venga ripetutamente menzionata nella letteratura. Il presente lavoro si presenta come un tentativo di colmare questi vuoti. I limiti del presente lavoro si possono ravvisare, innanzitutto, nelle scelte effettuate riguardo alla letteratura, e ai riferimenti presi in considerazione come materiale di riflessione. L’operare tali scelte è sembrato necessario allo scopo, perseguito dalla presente trattazione, di presentare una riflessione da un lato critica, dall’altro fruibile, sul tema del contenuto della parola prostituzione. Allo stesso tempo, l’occorrenza di una selezione è sempre puntualmente indicata (e motivata) nel presente lavoro. In secondo luogo, si è scelto di dare a questa trattazione un taglio esclusivamente teorico. Questa scelta è stata suggerita, da un lato, dall’obiettivo di sviluppare una riflessione organica e coerente su una materia, che, nella letteratura, non è quasi per nulla sviluppata, e, pertanto, pone la necessità di chiarimenti linguistici e concettuali; e, da un altro lato, dall’obiettivo di evidenziare, e presentare in maniera il più possibile chiara, la proposta originale che è contenuta nel presente lavoro. Tale scelta ovviamente non nega il valore di un confronto serrato tra riflessione teorica e ricerche empiriche su un dato oggetto di studio, e quindi anche sul tema affrontato qui. Infatti, da un lato, la presente trattazione non ignora il versante delle ricerche empiriche, ma lo incorpora nella forma di una riflessione teorica su di esso, dall’altro viene puntualmente affermata l’opportunità di riferirsi al dato empirico, e anzi questa affermazione è un punto fondamentale delle conclusioni del presente lavoro. Le conclusioni di questa riflessione teorica aprono alla ricerca empirica come conseguenza logica, da più punti di vista: non solo, infatti, si auspica che la ricerca empirica prenda in considerazione la proposta scaturente da tale riflessione come ipotesi, nell’ottica di un generale rapporto circolare tra riflessione teorica e ricerca
empirica, ma, poiché tale proposta, come si vedrà, ha una natura sostanzialmente metodologica, cioè si riferisce alla questione del conoscere la prostituzione, la ricerca empirica ne costituisce la conseguenza intrinseca, ontologica. Infine, le conclusioni alle quali la presente trattazione giunge, nella loro specificità e concretezza, nei fatti, culminano nel concetto che il terreno empirico sia il luogo privilegiato della possibilità di definire la prostituzione, e ciò ulteriormente rafforza il
legame concettuale con possibili successive ricerche empiriche. Al riguardo di possibili tentativi di operativizzare le riflessioni oggetto di questa trattazione, è possibile riscontrare, oltre alla già menzionata discussione metodologica di ordine generale, anche delle notazioni riguardo all’‘operativizzabilità’ della proposta che è presentata: soprattutto, ne vengono evidenziati alcuni vincoli fondamentali, oltre, come si è detto, all’opportunità del tentativo. Ulteriori considerazioni possono essere fatte sul tema, al fine di indicare anche possibili, concreti, sviluppi futuri del presente lavoro: rispetto alla proposta specifica che sarà esposta nella trattazione, appare particolarmente pertinente un approccio quali-quantitativo integrato informato alla metodologia menzionata, nella letteratura, con l’espressione Mixed Method Research . Quest’ultima, infatti, appare al contempo valorizzare e mettere a confronto l’approccio ‘oggettivo’ e ‘soggettivo’ al problema della conoscenza di un dato tema, e sembra pertanto adeguata a riflettere le premesse teoriche contenute nel presente lavoro. Data, infine, l’importanza delle rappresentazioni come grumi in cui si rapprende il tentativo di conoscere un dato tema (presentata e discussa nella presente trattazione), sembra opportuno suggerire che l’approccio empirico che dia seguito a ciò che qui è contenuto come proposta, sia sensibile alle questioni poste dall’uso del linguaggio (anch’esse in questo lavoro, seppur non approfonditamente, indicate), sia in fase di progettazione, sia in fase di concretizzazione, sia in fase di restituzione dei risultati della ricerca.Soggetto
Prostituzione; Linguaggio; Biopolitica; Gnoseologia; Conoscenza
Relazione
SPS/07;
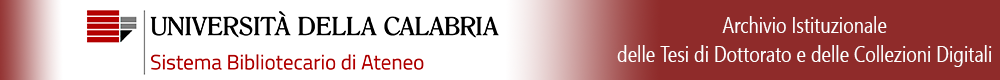
 Doctoral Thesis (1020.Kb)
Doctoral Thesis (1020.Kb)