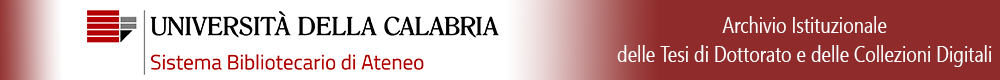Mostra i principali dati dell'item
Non dite che non vi avevo avvertito : cosa ci dicono le distopie contemporanee sulle paure del futuro : il caso italiano
| dc.contributor.advisor | Jedlowski, Paolo | |
| dc.creator | Cosentino, Nicola | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T12:33:52Z | |
| dc.date.available | 2025-03-25T12:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5594 | |
| dc.description | Dottorato di Ricerca in Politica, Cultura e Sviluppo. Ciclo XXXII | en_US |
| dc.description.abstract | Il testo propone una mappatura degli elementi distopici nel panorama letterario italiano, sulla base dei quali si è provato a ragionare su quali siano le principali paure della contemporaneità. La convinzione di partenza è che si possano intercettare i timori di una società studiando il modo in cui sono state raccontate dagli scrittori di narrativa, qui considerati come interpreti attenti della salute emotiva dei propri Paesi e del proprio tempo. Nello specifico, questa tesi prende in esame una porzione circoscritta – e perlopiù inesplorata – di opere letterarie provenienti dal solo panorama editoriale italiano, più precisamente romanzi scritti e pubblicati in Italia, accomunati da a) la presenza non marginale di elementi distopici che ne condizionano l’assetto, orientandoli il più possibile verso la fiction speculativa e la narrazione di altri mondi, altri tempi o di futuri in qualche modo plausibili e generalmente negativi e b) il fatto di essere stati scritti e pubblicati dopo il Duemila, data scelta per indicare, convenzionalmente, un cambio di passo nella storia della rappresentazione del timore e dell’incubo nelle forme narrative. In particolare, l’arco temporale a cui la mia ricerca si riferisce verte sui romanzi pubblicati dal 2008 fino alla chiusura del testo, risalente a ottobre 2019. Lo scopo è quello di verificare quali siano le paure più presenti nell’immaginario italiano, confrontandole ove possibile con quelle espresse, nel corso del tempo, da romanzi e film stranieri che abbiano trattato le medesime tematiche o, pur sempre con connotazioni distopiche, si siano significativamente concentrate su timori diversi. La tesi, nella sua forma testuale, si compone di quattro parti: un’introduzione, una storiografia del distopico, una parte monografica dedicata alle distopie italiane contemporanee e le conclusioni. La prima parte, intitolata Distopia è partecipazione, si suddivide in tre capitoli, ognuno dei quali indaga una tappa nel percorso della distopia: dal germe anti-utopico nelle parodie di Jonathan Swift ai primi viaggi nel tempo, dalle narrazioni anti-coercitive del Novecento alla profonda mutazione del realismo letterario contemporaneo, sempre più tentato dalle possibilità metaforiche offerte da un’ambientazione futuristica. L’ultimo capitolo di questa prima sezione, intitolato Cenni di storia della distopia in Italia, è da ritenersi propedeutico a quanto indagato ed espresso nella seconda parte. Esso costituisce una ricerca di per sé. È un vero e proprio viaggio di riscoperta negli elementi distopici della narrativa italiana, dalla messa in discussione dell’Utopia nelle opere di Ippolito Nievo e Luigi Pirandello ai “Mondi senza” tipici della fantascienza d’evasione e successivamente adottati da Giorgio Scerbanenco, Carlo Cassola e Guido Morselli; dalle fantastiche invenzioni nei racconti di Primo Levi ai temi dell’alterità, dell’alienazione e delle ibridazioni nei romanzi di Lino Aldani e Vittorio Curtoni. Infine, viene dedicato un paragrafo al “caso” Corrado Alvaro, autore di un romanzo distopico (L’uomo è forte, 1938) che anticipa di circa dieci anni le tematiche espresse da George Orwell in 1984 (1949). La sezione monografica è stata suddivisa per tipologie di paure: epidemie e disastri naturali, ovvero apocalissi “fisiche”, divise tra salute dell’uomo e salute della Terra; spersonalizzazione e svalutazione, perdita di valori, di affetti, della memoria; sistemi sovvertiti e alterità: nuovi ordini mondiali, tra denaro, fine del lavoro ed emarginazione. Nella prima categoria rientrano alcuni esempi italiani di climate fiction, ovvero i romanzi che affrontano il discorso sul cambiamento climatico, come Qualcosa, là fuori di Bruno Arpaia, o la possibilità di un collasso energetico, come Le cose semplici di Luca Doninelli. Si tratta, naturalmente, di esempi di storie post-apocalittiche finalizzate a indagare o a denunciare le cause della finis mundi per cause naturali, per poi raccontarne le dure conseguenze. Il capitolo lascia spazio anche al post-apocalittico “decorativo”, ovvero ai romanzi che raccontano un mondo desolato, violento e regredito senza soffermarsi eccessivamente su ragioni alla base del peggioramento: è il caso di Voragine di Andrea Esposito. La seconda categoria fa luce sul terrore, complesso e affascinante, della mortificazione dei sentimenti, dell’età, della memoria, della complessità. Il discorso relativo a questo specifico tipo di svalutazione ruota spesso intorno alla tecnologia e al suo innesto, in termini più o meno invasivi, nella nostra quotidianità. Si oscilla, dunque, dal ruolo del social network come pretesto per la menzogna, l’alienazione e l’esasperazione (Panorama, Tommaso Pincio) al valore del linguaggio e del dialogo umano, coacervo di complessità “vive” e in divenire, confrontato a quello statico, non esperienziale, delle intelligenze artificiali (History, Giuseppe Genna). Viene citato, inoltre, il romanzo di Michele Vaccari Un marito, come esempio di “distopia privata”, ovvero una narrazione in cui si gestisce l’individuo come fosse un intero universo, e la sua tragedia personale quella di un’intera umanità. La terza categoria riprende narrazioni distopiche più vicine a quelle “classiche”, e che focalizzano l’attenzione sul sovvertimento di uno status quo ante che somiglia al presente reale, del lettore. Il protagonista di Cinacittà di Tommaso Pincio si aggira per una Roma ormai abitata e “gestita” da soli cinesi, in cui residenti originari, chiamati nel romanzo “romani” e mai “italiani”, sono considerati una minoranza. Qualcosa di simile accade nei territori razziati dai barbari ne L’uomo verticale di Davide Longo e tra le comuni post-apocalittiche visitate dai documentaristi protagonisti di La festa nera, di Violetta Bellocchio: l’umanità, in questi romanzi, è impegnata in uno scontro tra alterità, tra minoranze disperate, armate l’una di un odio ingiustificato e l’altra della propria paura e del proprio istinto di sopravvivenza. Meno selvaggio il quadro dipinto da Fabio Deotto, con Un attimo prima: nella sua Milano futura, a seguito di una rivoluzione innescata dal Movimento Occupy, non esiste più il denaro e il lavoro è un concetto astratto, molto marginale. Esistono, però, gli emarginati, i “non ammessi” al nuovo sistema. Nello stesso scenario, dunque, si confrontano utopia e distopia. L’intera seconda parte si apre con una premessa in cui si prova a dimostrare la connessione tra le paure degli italiani successive alla crisi del 2008, l’incremento delle narrazioni distopiche e le tematiche in esse espresse, grazie a una mappatura stilata negli anni di ricerca (e che non ha pretese di esaustività) dei romanzi distopici “mainstream” pubblicati in Italia negli ultimi vent’anni e di alcune statistiche relative ai timori più sentiti dalla popolazione. Verrà dimostrato che dati, tempi e timori convergono. | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SPS/08; | |
| dc.subject | Distopia | en_US |
| dc.subject | Romanzo | en_US |
| dc.subject | Paura | en_US |
| dc.subject | Società | en_US |
| dc.subject | Futuro | en_US |
| dc.title | Non dite che non vi avevo avvertito : cosa ci dicono le distopie contemporanee sulle paure del futuro : il caso italiano | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |